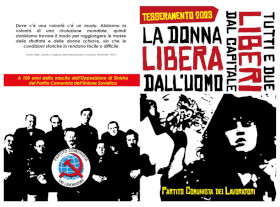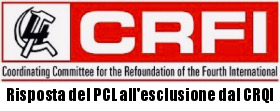Prima pagina
Industria delle armi e imperialismo italiano
5 Dicembre 2024
La vittoria di Trump negli USA è un ulteriore fattore di traino della corsa alle armi in Europa. La corsa è partita da almeno un decennio in tutti gli stati imperialisti del vecchio continente. L'invasione russa dell'Ucraina ha accelerato il suo passo. Ora il passo diventa affannoso.
Già prima delle elezioni americane, e del loro esito prevedibile, il rapporto Draghi aveva sottolineato l'esigenza di una “difesa comune europea” attraverso due vie tra loro combinate: il reperimento delle enormi risorse necessarie con un nuovo indebitamento straordinario continentale (un incremento di 800 miliardi annui, il 5% del PIL dell'Unione Europea), e la progressiva unificazione a livello europeo del complesso industriale-militare. Ma entrambe le vie appaiono ostruite. Da un lato, l'imperialismo tedesco, in profonda crisi, non vuole accollarsi i costi di un nuovo debito europeo. Dall'altro, i diversi monopoli delle industrie militari nazionali sgomitano gli uni contro gli altri per accaparrarsi le accresciute commesse e guadagnare spazi di mercato.
Anche le cooperazioni aziendali transnazionali, che pur si moltiplicano, seguono questa rotta.
La concorrenza nella produzione degli aerei di combattimento è emblematica. Gran Bretagna, Germania, Spagna, Italia cooperano nella produzione di Eurofighter, la Francia punta sul proprio Rafale, la Svezia produce il Gripen. Il futuro cacciabombardiere di sesta generazione (Tempest) vede la collaborazione di aziende britanniche, italiane, giapponesi, con la benedizione dei rispettivi governi, ma la Francia gli contrappone un proprio progetto (Future Combat Air System), non volendo collaborare con l'industria militare britannica. Così l'industria militare americana mantiene saldo il proprio primato, e incassa buona parte delle stesse commesse militari europee, con la relativa protesta della Francia.
La spesa militare europea (313 miliardi di dollari nel 2023) è complessivamente il triplo di quella della Russia (che pur è cresciuta nel solo 2023 del 24%), ma resta segnata da una forte frammentazione.
L'imperialismo italiano si muove in questo quadro d'insieme.
La spesa militare italiana è in crescita da dieci anni (+ 61%). E non ha atteso, come molti pensano, la guerra d'Ucraina. Nel 2020, in piena tempesta Covid, il governo presieduto da Giuseppe Conte (quello che oggi fa il “pacifista”) aumentò la spesa militare in un solo anno del 9,6%, dopo aver concordato in sede NATO il famoso impegno per la prospettiva del 2% del PIL. La profonda crisi recessiva a ridosso della pandemia rallentò parzialmente la corsa. Ma l'attuale governo Meloni-Crosetto si impegna a recuperare i “ritardi”, portando la spesa militare al tetto record di 32 miliardi di euro, e le sole spese in nuovi armamenti ad oltre 13 miliardi annui (40 miliardi nel triennio). Ciò che si è tolto a reddito di cittadinanza, sanità, scuola, servizi lo si investe (anche) nel militarismo. Colpisce il raffronto con la spesa prevista per il dissesto idrogeologico: 1,8 miliardi.
Le aziende militari tricolori si muovono nel solco di questa dinamica.
L'azienda Leonardo (ex Finmeccanica), fiore all'occhiello del militarismo patrio, è in piena espansione di utili e di affari. Attualmente è la seconda azienda militare in Europa alle spalle della britannica BAE Systems, con un fatturato che supera gli 11 miliardi. Ma le sue mire vanno oltre. Leonardo punta ad allargare la produzione di elicotteri militari (con cui già equipaggia lo stato sionista) attraverso la collaborazione con Airbus; prova a scalare posizioni nell'economia dello spazio, facendo leva sulla forte partecipazione azionaria (33%) a Thales Alenia Space. Soprattutto, investe sulla produzione di un nuovo carro armato pesante europeo, detto Main Ground Combat System. Decisiva al riguardo la joint venture con la tedesca Rheinmetall, con sede operativa presso la OTO Melara di La Spezia. Mentre un'altra azienda tedesca, Krauss-Maffei Wegmann (gruppo KNDS) che produce il già noto Leopard, gli contende il mercato.
Parallelamente corre Fincantieri. Il suo balzo in Borsa nell'ultimo anno è del 34%. Ha oggi in portafoglio ordini per 41,1 miliardi. Il suo principale obiettivo di investimento è rappresentato dai sommergibili: un mercato mondiale che vale oltre i 400 miliardi.
Le dinamiche di guerra sospingono il grande affare. Come afferma il Corriere della Sera (11 novembre), «i sommergibili sono tra i mezzi più temuti: possono servire per mappare in segreto le infrastrutture critiche dei Paesi nemici oppure, nello scenario peggiore, per sabotare o attaccare le navi commerciali e militari».
I fondali marini peraltro sono più che mai territorio strategico, ospitano oltre 1,4 milioni di km di cavi sottomarini, sui quali scorrono quotidianamente dati e transazioni finanziarie. Nel solo Mediterraneo oltre 320 mila km di gasdotti e oleodotti.
Nella sua storia, Fincantieri ha prodotto più di 180 sommergibili, ed oggi è in prima fila per onorare la nuova domanda tricolore. Sia attraverso la produzione di droni subacquei, con e senza pilota, «mezzi economici e tremendamente efficaci... per la difesa e, nel caso, anche per l'attacco» (Corriere); sia attraverso la progettazione di nuovi sottomarini nucleari commissionati a Fincantieri dal ministero della Difesa, con tanto di coinvolgimento dell'Università di Genova. È il Piano nazionale per la ricerca militare 2023: si chiama "Minerva – Marinizzazione di impianto nucleare per l'energia di bordo di vascelli armati”.
La grande ambizione di Fincantieri è mettere le mani sulla tedesca ThyssenKrupp Marine Systems, e sui cantieri navali di Kiel, specializzati nella costruzione di navi e sottomarini miliatari. Magari attraverso una joint venture paritetica che consentirebbe un salto enorme di capacità produttiva e peso globale.
La crescita dell'industria militare italiana si combina col ruolo dell'imperialismo patrio su scala internazionale. Sale, non a caso, la spesa programmata per le missioni militari in cui l'Italia è coinvolta, spesso con un ruolo rilevante.
È il caso del ruolo dell'Italia in Medio Oriente. Innanzitutto nel Mar Rosso, in una missione militare votata in parlamento da un ampio fronte di unità nazionale – da Fratelli d'Italia al M5S, passando per il PD – apertamente schierata contro gli houti, a difesa delle navi dirette verso i porti della Palestina occupata. Cioè a difesa di Israele.
Ma anche in Libano, dove l'Italia ha un ruolo centrale nella cosiddetta “missione di pace” UNIFIL (1200 uomini). Una missione intrapresa nel 1978, e poi molto rafforzata nel 2006 col concorso decisivo del governo di Romano Prodi (cui partecipava Rifondazione Comunista). Una missione nata originariamente con lo scopo (fallito) di favorire il disarmo di Hezbollah da parte del governo libanese al fine di compensare e riscattare la sconfitta dell'invasione israeliana del Libano di allora; ed oggi impegnata a rinegoziare con le autorità libanesi il disarmo di Hezbollah sotto la frusta della nuova guerra d'invasione sionista, sullo sfondo del massacro dei palestinesi.
Tanto più oggi l'”applicazione” della famosa risoluzione ONU 1701, quale soluzione di “pace”, significa infatti esattamente questo: aiutare la ricostruzione di una forza militare libanese che possa completare, il più possibile “pacificamente”, il lavoro sporco dello stato sionista, con la benedizione degli altri attori regionali e degli alleati imperialisti. Meloni e Crosetto chiamano “pace” un Libano ripulito dalla resistenza filopalestinese. A tal fine chiedono agli imperialismi alleati di concordare nuove regole d'ingaggio per la missione UNIFIL. Nel mentre, candidano i Carabinieri al ruolo di addestratori di una futura polizia militare per l'ordine pubblico in Palestina, ruolo peraltro già svolto al servizio della polizia di ANP in Cisgiordania.
Ma l'impegno dell'imperialismo italiano si proietta su scala globale, ben al di là del Medio Oriente. «Manovre nel Mar Cinese del Sud, la prima volta delle navi italiane»: così il quotidiano liberalprogressista La Repubblica (13 settembre) saluta enfaticamente il ruolo della portaerei Cavour nelle operazioni militari sul Pacifico.
Per la “prima volta” una portaerei italiana guida un gruppo navale composto da navi americane, francesi, spagnole, tedesche, australiane, giapponesi. «Il gruppo è salpato da Taranto a inizio giugno, ha attraversato il canale di Suez e nel Mar Rosso sono iniziate le attività di addestramento con la portaerei USA Roosevelt, e poi proseguite in Australia partecipando all'esercitazione Pitch Black che ha visto trasferire nelle basi dell'Oceania jet da combattimento delle ultime generazioni...» (La Repubblica). L'addestramento passa per due simulazioni di combattimento: la prima ha visto impegnati i modernissimi caccia F-35B e i più stagionati Harriera nel respingimento virtuale di «squadriglie nemiche»; la seconda ha visto l'azione coordinata di navi, aerei, elicotteri per «dare la caccia a una minaccia negli abissi».
Il ministro Crosetto ha motivato le operazioni, e la relativa partecipazione italiana, con queste parole: “Stiamo stringendo legami più profondi con paesi amici, perché vogliamo mantenere la libertà di navigazione e la sicurezza marittima in questa regione al fine di promuove il commercio e proteggere le catene di approvvigionamento”. Cosa non si fa per la “libertà”...
Il Pacifico si configura sempre più, in prospettiva, come il principale teatro della collisione tra imperialismo USA e imperialismo cinese. Un imperialismo in declino ma ancora dominante e un imperialismo in ascesa con ambizioni crescenti. È la rotta potenziale di una futura grande guerra per la spartizione del mondo. L'estensione della NATO sul Pacifico, con l'arruolamento di Giappone, Corea del Sud, Australia è parte della preparazione alla guerra. Come lo è, sul versante opposto, la stretta cinese su Taiwan. L'imperialismo italiano non è spettatore ma partecipe della grande alleanza a guida USA. E non vuole restare in seconda fila. Come non lo vogliono Leonardo e Fincantieri. L'imperialismo di casa nostra è innanzitutto l'imperialismo tricolore.