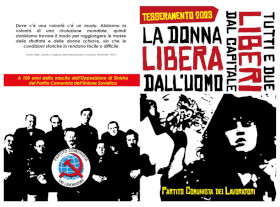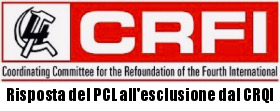Dalla tragedia alla farsa. Lo stalinismo ieri e oggi
La Cina del Grande Timoniere (seconda parte)
Mao e il maoismo italiano: una politica opportunista e fallimentare da archiviare per sempre, anche nel mito
4 Febbraio 2021
Il fraintendimento della Rivoluzione culturale e dell’esperienza cinese, vista come novità radicale e libertaria nel panorama del comunismo mondiale. Millenarismo e ascetismo messi al servizio degli scontri di potere all’interno della burocrazia cinese. La ricezione del maoismo in Italia e le principali differenze col marxismo rivoluzionario (seconda parte)
Leggi qui la prima parte
Il proletariato aveva assistito fino a quel momento – 1966 – in maniera passiva allo sviluppo degli avvenimenti. Tuttavia, il suo stato d’apprensione aveva continuato ad aumentare. La mitizzazione di un “comunismo ascetico”, cinicamente utilizzata dalla frazione maoista come base ideologica della mobilitazione studentesca, l’accento posto sulla necessità di dedicare lungo tempo allo studio del pensiero di Mao Tse-tung, la lotta dichiarata verso l’“economicismo”, tutto ciò veniva visto come un potenziale attacco alle condizioni di vita del proletariato. In più i pochi interventi delle Guardie rosse maoiste presso gli operai, tutti incentrati intorno alla demagogia reazionaria dei sacrifici e dello studio, acutizzano la tensione. Non è quindi difficile, per i quadri antimaoisti della burocrazia, spingere allo sviluppo del movimento del proletariato. In autunno scoppiano vasti scioperi operai un po’ in tutta la Cina, mentre organizzazioni di Guardie rosse filo-liuliste nascono in diverse fabbriche. Si giunge un po’ dovunque a scontri sanguinosi tra operai e studenti.
Un aspetto estremamente importante della situazione è che, pur essendo chiari la diffidenza e l’astio delle masse operaie per le Guardie rosse studentesche e per la cosiddetta Rivoluzione culturale proletaria, una loro mobilitazione in senso puramente antimaoista (ovviamente nei fatti, perché dovunque i liusti si presentano come i veri difensori del pensiero di Mao Tse-tung) sarebbe stata impossibile, soprattutto tenuto conto che una parte notevole del proletariato non aveva certo molta simpatia per i quadri dirigenti locali del partito, dello Stato e dei sindacati, che costituivano l’asse fondamentale della frazione liuista.
La mobilitazione della classe operaia avviene intorno ad autentiche rivendicazioni proletarie, come la lotta contro i ritmi, le differenziazioni salariali tra zone diverse e tra piccole e grandi fabbriche, e per la riduzione del periodo di apprendistato, per la diminuzione dell’orario di lavoro (48 ore), per gli aumenti di salario e, soprattutto, contro il sistema antiproletario e antipopolare detto “operaio-contadino”, cioè l’impiego dei contadini nelle fabbriche durante le stagioni morte per l’agricoltura, a paga inferiore agli altri operai, senza protezione sociale e senza il diritto di iscriversi ai sindacati.
Inizialmente la frazione maoista aveva apertamente condannato le agitazioni operaie. Ma il pericolo diventò presto troppo grande e, a malincuore, i maoisti sono costretti a ripetere verso la classe operaia l’operazione che i liuisti avevano compiuto verso gli studenti. È tempo, perché le concessioni che i quadri dell’apparato minacciati dalla Rivoluzione culturale si apprestano a fare, per demagogia, alla masse operaie, possono diventare un potente strumento per la frazione liuista. I maoisti sono costretti a cercare di seguirli su questa strada. Nelle fabbriche nascono così i primi gruppi di Guardie rosse realmente legati alla frazione maoista. Anche qui si riproducono scontri tra le diverse frazioni, anche se, al contrario che nel movimento studentesco, le Guardie rosse legate ai liusti sono nettamente maggioritarie rispetto a quella maoiste. Questo anche perché, pur proclamando la necessità della Rivoluzione culturale anche nelle fabbriche, i maoisti continuano a condannare pubblicamente gli scioperi.
La situazione si complica ulteriormente. Le fratture tra le diverse organizzazioni di Guardie rosse si moltiplicano, senza avere più, a volte, alcun riferimento alle divisioni al vertice del partito. In ogni situazione locale lo scontro tra le forze in lotta assume caratteristiche specifiche. A gennaio del 1967 il caos regna in Cina. Ne è un esempio lampante Shanghai. Qui il movimento degli scioperi operai sfugge, nonostante una politica di concessioni, ad ogni controllo, anche dei quadri di base dell’apparato burocratico locale, che vengono duramente attaccati (sciopero generale di fine dicembre ‘66). Poi i “ribelli rivoluzionari” (studenti e una minoranza attivista della classe operaia), che pur avevano combattuto gli scioperi in nome della reazionaria parola d’ordine di Mao “fare la rivoluzione e stimolare la produzione” ed erano stati lo strumento della frazione maoista, il 5 febbraio 1967 proclamano la Comune di Shanghai, rivendicando tra l’altro “elezioni generali del tipo di quelle della Comune di Parigi”, cioè le forme della democrazia operaia. Il pericolo per la burocrazia è evidente. Se in tutta la Cina in movimento degli scioperi operai si fosse congiunto con le forze di sinistra emergenti tra i “ribelli rivoluzionari”, le possibilità di una esplosione realmente rivoluzionaria sarebbero state enormi. L’apprendista stregone Mao corre il rischio di scatenare le forze latenti della rivoluzione antiburocratica.
Tuttavia, niente del genere si realizza. Le masse operaie mobilitate negli scioperi non riescono a darsi una prospettiva politica generale, nemmeno quando, come a Shanghai, rompono totalmente con gli elementi liuisti che cercano di utilizzarle. D’altro canto le forze di sinistra emergenti tra i “ribelli rivoluzionari”, pur criticando ed attaccando a volte tutto il sistema e tutti i dirigenti (escluso Mao, ma compreso Lin Piao e il Gruppo centrale della Rivoluzione culturale), non riescono a comprendere i meccanismi reali della crisi politica e soprattutto non sono in grado di rompere con l’idealismo reazionario ed ascetico da “comunismo della povertà” su cui erano stati mobilitati ed utilizzati dalla frazione maoista.
Mancava ovviamente un partito o quantomeno un’organizzazione realmente bolscevica che sola avrebbe potuto compiere il collegamento tra gli elementi più avanzati di entrambi i movimenti di massa e indirizzare la loro azione contro la burocrazia nel suo complesso. Nell’inverno del 1967, comunque, l’apparato dello Stato e del partito è sconvolto, in ogni città si svolgono (e si svolgeranno ancora per tutto il corso dell’anno) scontri sanguinosi tra le diverse fazioni delle guardie rosse che provocano, secondo i giornali cinesi, centinaia e a volte migliaia di morti.
L’unico organismo che è rimasto in piedi in questa situazione di confusa anarchia è l’esercito, saldamente nelle mani di Lin Piao dal gennaio 1966. E all’esercito viene adesso assegnato il compito di riequilibrare la situazione. L’opera d’intervento delle forze armate si sviluppa nei mesi successivi. La sua base è la lotta per la “triplice unione”, cioè la creazione, come nuovi organi di poteri, di organismi formati congiuntamente da “rappresentanti delle masse, del partito e dell’esercito”. Questa nuova struttura, basata su nomine dall’alto e senza alcun aspetto di democrazia proletaria, è lo strumento che agli occhi della direzione maoista può permettere la ripresa in mano della situazione e della ricostituzione del partito ormai sconvolto, senza andare ad uno scontro diretto con i “ribelli rivoluzionari”. Essa implica la congiunzione al vertice del PCC tra la frazione Mao-Lin Piao e gli elementi intorno a Chou En-lai come mezzo per raccogliere nel partito “rinnovato” la stragrande maggioranza dei vecchi quadri a tutti i livelli. Quanto a Liu, Deng e ai loro più diretti alleati ai massimi vertici del partito, le cose sono andate troppo in là per sperare di recuperarli. Devono essere epurati, anche se questa epurazione sarà diversa da persona a persona, come dimostra la storia successiva di Deng. Dovunque l’intervento dell’esercito assume queste caratteristiche: spinta all’unificazione di più organizzazioni possibili di Guardie rosse sulla base della politica della triplice alleanza, reinserimento nel partito rinnovato del maggior numero possibile di vecchi quadri, attacco definitivo alle organizzazioni di Guardie rosse. Questa politica di liquidazione degli “ultrademocraticisti” è stata estremamente dura e sanguinosa, giungendo a volte a vere e proprie battaglie tra l’esercito e i ribelli.
Entro l’ottobre del 1968 tutti i comitati provinciali sono formati e la situazione è ritornata ovunque alla normalità. Il 13 di quel mese si tiene il XII plenum del Comitato Centrale che ratifica questa conclusione della Rivoluzione culturale, tra l’altro decidendo ufficialmente (solo ora!) l’espulsione dal partito e la perdita di tutte le cariche per Liu Shao-ch’i. Ma se, pur in forme impreviste, la frazione maoista ha sostanzialmente realizzato i suoi obiettivi iniziali, è soprattutto una persona che si presenta come il vero grande vincitore della Rivoluzione culturale: il maresciallo Lin Piao.
È Lin Piao che tiene il rapporto principale al IX congresso del PCC che si riunisce nell’aprile del 1969. In un clima di catechizzazione e di misticismo di massa attorno al pensiero e alla figura di Mao, Lin Piao viene ufficialmente proclamato delfino e successore del “Grande Timoniere”. In apparenza Lin Piao è inattaccabile. Ma ha raccolto troppo potere e questo provoca l’ostilità e la volontà di rivincita non solo dei quadri recuperati e Chuoisti, ma anche del “clan” maoista. La crisi politica interna alla burocrazia cinese è lungi dall’essere finita. Essa proseguirà con la liquidazione politica dell’ex principale dirigente della “Rivoluzione culturale” e segretario di Mao, Chen Po-ta, probabilmente oppositore del recupero ampio dei quadri della frazione Liu-Deng. Poi sarà la volta dell’ex “delfino designato” Lin Piao, liquidato anche fisicamente (aereo abbattuto nei cieli della Mongolia o meno) nel 1971 con i suoi più stretti sostenitori. Tutti questi conflitti avvengono nel chiuso delle stanze del potere, lontano dal sia pur minimo coinvolgimento delle masse, degli iscritti o anche dei quadri intermedi del partito.
Una differenza abissale con il dibattito e il confronto aperto e pubblico conosciuto dal Partito bolscevico prima del trionfo dello stalinismo. La realtà dello scontro di cricche all’interno del PCC mostrava la reale natura del regime cinese: un totalitarismo burocratico. In questo quadro la Rivoluzione culturale si mostra per quello che era stata. Una cinica mobilitazione della gioventù studentesca da parte di una delle frazioni in lotta per il potere intorno a una fasulla demagogia di “ascetismo egualitarista” e il contrario tentativo, questo più difficile e politicamente fallito, della fazione opposta di contrapporvi gli operai sulla base delle loro rivendicazioni economiche. Una miscela divenuta ad un certo punto esplosiva per il potere della burocrazia stessa e quindi regolata con l’intervento repressivo di quello che in uno Stato operaio degenerato, come in uno Stato borghese, rimane uno dei bastioni dei dominatori reali della società: l’esercito.
LE REAZIONI NEL MAOISMO ITALIANO: LE TRE SCIMMIETTE (“NON VEDO, NON SENTO, NON PARLO”)
Come detto, le organizzazioni maoiste italiane avevano visto la Rivoluzione culturale come un movimento di radicale rinnovamento in positivo della società cinese. Di fronte a ciò avevano colpevolmente taciuto su tutti quegli aspetti che a prima vista appaiono abnormi.
In primo luogo, l’aberrante culto della personalità di Mao, che veniva presentato come una specie di semidio. Tanto più grave questo atteggiamento per organizzazioni come Lotta Continua, Avanguardia Operaia e Il Manifesto, che si dichiaravano antistaliniste.
Ancora più grave fu l’atteggiamento rispetto allo sviluppo dello scontro burocratico all’interno dei “vincitori” in Cina: anche considerando che, a parte il filone “m-l ortodosso”, le altre più grandi e più importanti organizzazioni maoiste nacquero nella fase finale della Rivoluzione culturale, mentre erano ormai consolidate nel 1971.
La loro reazione fu appunto come quella delle tre scimmiette dell’immagine popolare: “non vedo, non sento, non parlo”. Per una manifestazione alla fine del 1971 a Milano, la più sinistra di esse, Avanguardia Operaia, lanciò lo slogan “Mao, Lin Piao, Chen Po-ta: la rivoluzione continuerà!”, apparentemente senza rendersi conto del ridicolo di accomunare i capi delle varie frazioni (o sotto frazioni) che si erano affrontate con tutti i mezzi, comprese le uccisioni nello scontro per il potere. Ma fu lo spazio di un breve momento. La stessa Avanguardia Operaia ritirò dalla distribuzione tutte le copie del suo settimanale che conteneva un articolo di Vincenzo Sparagna che titolava “Si accentua la svolta a destra della Cina”, riferita anche agli sviluppi della politica estera cinese, e lo sostituì con un numero con un articolo alternativo nella pagina “incriminata” che parlava di tutt’altro argomento.
Questo vergognoso atteggiamento delle organizzazioni maoiste italiane mostrava al contempo la loro lontananza da ogni metodologia marxista e leninista e la loro mancanza di internazionalismo reale. Rispetto alla prima questione perché sempre le organizzazioni marxiste hanno dibattuto e confrontato apertamente i grandi avvenimenti politici, compresi quindi quelli occorrenti in seno al movimento operaio. Rispetto alla seconda questione perché l’atteggiamento dei gruppi dirigenti centristi era intriso dello spirito del tipo: “Sono cose dei cinesi, noi pensiamo all’Italia”. Fermo per tutti il mantenimento – per utilità politica ed ostilità all’unica alternativa analitica, teorica e programmatica possibile, cioè il trotskismo – il riferimento al maoismo, cioè alla versione cinese dello stalinismo.
In questo senso si può ben affermare che i Gorla, Vinci, Sofri, Rossanda, Magri, nell’alternativa storica tra trotskismo e stalinismo, al di là della retorica “anti”, si sono posti più dal lato della barricata dello stalinismo e della sua tradizione.
LA POLITICA ESTERA DELLA CINA DEL “GRANDE TIMONIERE”: SPECCHIO DEL CARATTERE CONTRORIVOLUZIONARIO DELLA BUROCRAZIA DI PECHINO
Abbiamo già visto che la politica estera cinese, al di là dell’immagine retorica, esprimeva anche nella fase della Rivoluzione culturale, in particolare proprio per la frazione maoista, un approccio sostanzialmente moderato, teso in primo luogo ad evitare la ripetizione dell’“incidente coreano” dei primi anni ‘50. Ma sarà dopo la fine della Rivoluzione culturale, una volta ristabilito il quadro dello Stato burocratico, che essa potrà riprendere, svilupparsi e mostrare tutto il suo carattere controrivoluzionario.
Negli anni Cinquanta e Sessanta, dopo la fine della guerra di Corea, la politica estera cinese si era basata fondamentalmente su una tipica concezione da stalinismo maturo, di alleanza con le cosiddette “borghesie nazionali” (riproposizione in un nuovo quadro delle vecchie concezioni mensceviche nel movimento operaio russo di prima del 1917). In questo quadro si inseriva il cosiddetto movimento dei “non allineati”, costruito a metà anni ‘50 con la Jugoslavia di Tito, l’India di Nerhu, l’Indonesia di Sukarno, l’Egitto di Nasser, etc., che rivendicava una coesistenza pacifica sul piano internazionale, che significava blocco di ogni prospettiva rivoluzionaria su scala di ogni singolo paese. Del resto, il ruolo della Cina si era già visto alla conclusione del primo conflitto vietnamita (1954), quando essa, più dell’URSS, si era mossa per limitare, con un compromesso bidone, i risultati del successo politico dei vietnamiti sul campo.
Benché il movimento dei non allineati entrasse in crisi a causa del conflitto (per motivi di confine) tra India e Cina, per tutto il periodo precedente la Rivoluzione culturale la politica cinese rimase quella indicata.
I tragici risultati di questa collaborazione di classe con la borghesia nazionale si videro nell’unico paese in cui un grande partito comunista a base di massa si era schierato con Pechino e non con Mosca, cioè l’Indonesia. Qui i militari reazionari, con l’aiuto degli USA, realizzarono nell’ottobre del 1965 un colpo di stato contro la presenza nell’area di potere del PC indonesiano, in alleanza subordinata con il borghese “progressista” Sukarno (che cercò di allinearsi ai golpisti, ma fu messo in disparte nel giro di pochi mesi). Fu un massacro senza precedenti, mezzo milione di militanti e iscritti del PCI (e di altre forze minori di sinistra, compreso il trotskista Partai Acoma, che aveva anche una piccolissima presenza parlamentare) furono assassinati e la presenza del movimento operaio organizzato, che risaliva all’inizio del ‘900, distrutta, anche a causa dell’impreparazione e delle illusioni create dalla collaborazione di classe con la borghesia nazionale, in nome della teoria della “rivoluzione a tappe”.
Nel periodo della Rivoluzione culturale la politica estera era l’ultimo dei problemi della direzione stalinista cinese. Le uniche indicazioni apparivano all’ingenuità dei maoisti nostrani molto “radicali”: in particolare come detto, la teoria delle “campagne che accerchiano le città” [1] o l’invito alla resistenza senza compromessi del Vietnam (come diranno poi i dirigenti vietnamiti “Mao era sempre pronto a lottare... fino all’ultimo vietnamita”), accompagnato da scarso sostegno reale.
Fu con il riconsolidamento del regime burocratico che la politica estera cinese tornò ad essere fattore importante su scala mondiale e proprio il gruppo dei vincitori della Rivoluzione culturale, cioè la frazione maoista fatta partito, espresse le posizioni più reazionarie mai avute dalla burocrazia cinese, in quella che fu una sostanziale alleanza con l’imperialismo USA contro l’URSS e contro ogni ipotesi rivoluzionaria in ogni paese del mondo.
Quello che infatti determinava la politica maoista non era una prospettiva di rivoluzione (fosse pure confusa) o di trasformazione sociale sul piano internazionale, ma gli interessi nazionali della casta parassitaria a cui tutto doveva essere subordinato. In questo quadro il nemico principale diventava l’URSS e il suo “socialimperialismo”. La situazione mondiale veniva indicata come quella della lotta mondiale tra due superpotenze. E ciò non portava ad una pur errata posizione di “equidistanza” nello scontro (ovviamente il proletariato e la lotta di classe non entravano nelle considerazioni di Mao e soci), ma ad indicare nell’URSS il nemico principale contro il quale ogni alleanza era possibile e dovuta. Una ripetizione della peggiore politica stalinista, tipo patto Hitler-Stalin, ma qui argomentata presentando come hitleriana l’URSS! Scriveva per esempio l’ufficiale Quotidiano del Popolo (9 maggio 1975): “L’Unione Sovietica è oggi una dittatura della borghesia, una dittatura della grande borghesia, una dittatura di tipo fascista tedesco, una dittatura di tipo hitleriano [..]. Le due superpotenze, Unione Sovietica e USA, sono attualmente impegnate in un fiero conflitto per l’egemonia internazionale. L’ultimo venuto, il socialimperialismo sovietico, che nutre sogni di dominio ed allunga le mani dappertutto, si fa in quattro per sostituire gli imperialisti USA, che stanno diventando sempre più vulnerabili e strategicamente passivi. Cerca di prendere la strada di Hitler, verso il dominio mondiale”. Ecco il linguaggio da estrema destra conservatrice americana che propinava l’organo ufficiale del “Grande Timoniere”.
Non è qui possibile ovviamente seguire tutti gli aspetti della politica estera cinese di quegli anni, ci limiteremo ad indicarne alcuni tra i principali esempi. L’anno di svolta fu il 1971 con un viaggio cinese, poi svelato, del criminale imperialista Henry Kissinger a Pechino, che preparò la visita ufficiale del reazionario presidente statunitense Nixon nel febbraio dell’anno successivo – accolto con tutti gli onori mentre su Hanoi cadevano le bombe – che sanciva la nuova alleanza internazionale.
In quello stesso anno in tre occasioni importanti il regime cinese mostrò il volto della sua politica estera.
In primo luogo, appoggiò la feroce repressione del regime militare pakistano del generale Yahya Khan contro la rivolta indipendentista del Bangladesh. Salutò poi la sconfitta, da parte del dittatore bonapartista sudanese Numeyri, di un tentativo di colpo di stato da parte di settori di sinistra dell’esercito. Tale sconfitta portò alla liquidazione sanguinosa di quello che era allora il più importante Partito comunista del mondo arabo e dell’Africa e dei sindacati di massa da esso diretti. La Cina giunse ad offrire aiuto economico e militare a Numeyri. Aiuto che venne poi effettivamente dato, nei limiti delle necessità, ad un governo di “fronte popolare” in Sri Lanka impegnato nella sanguinosa repressione (15000 morti tra ogni atrocità) di una rivolta giovanile, lanciata da una organizzazione grosso modo definibile “castrista” (che però si richiamava anche alla strategia maoista della guerra di popolo). Fu poi nei riguardi nei riguardi del golpe di Pinochet che la politica cinese raggiunse nuovi abissi di ignominia. Per la burocrazia di Pechino la lotta di classe non esisteva. Quello che avveniva in Cile era solo uno scontro tra le due superpotenze (il governo Allende era dunque solo uno strumento di Mosca) e tra di esse, come visto, la Cina sceglieva quella “non hitleriana”, e cioè l’imperialismo Usa. Affermava, pochi mesi dopo il golpe, Pekin Information (agenzia ufficiale in lingua estera del regime maoista, 22 giugno 1974): “In America Latina oltre alla loro disputa militare, la rivalità delle due superpotenze si era esacerbata nel settore politico, diplomatico ed economico. Il colpo di stato militare sopraggiunto in Cile nel 1973 è stato un effetto di questa rivalità accresciuta [..]. Dopo il colpo di stato militare in Cile, i revisionisti sovietici sono divenuti più attivi nel continente sudamericano, per assicurarsi un nuovo punto d’appoggio”. Così l’11 settembre del 1973 e nei giorni successivi, mentre migliaia di militanti di sinistra trovavano scampo dalle repressioni nelle ambasciate di Santiago (persino quella della Spagna, ancora franchista, aprì le sue porte), una sola rimase ermeticamente chiusa e tutti coloro che bussarono chiedendo asilo (alcuni di loro tra i pochissimi maoisti locali) furono respinti: quella della “Cina Popolare”. Del resto, la Cina avanzò rapidamente offerte di accordi economici e addirittura finanziamenti al regime dei boia reazionari. Di questo atteggiamento ne diede atto niente meno che Pinochet in persona, il quale in un’intervista al New York Times del 29 novembre ‘73 affermò: “La Russia e Cuba cercano di riprendersi le loro posizioni, di fare del Cile quella loro base sudamericana che era sotto Allende. Allora questo paese era il centro delle loro attività in tutto il continente, centro di guerriglia, distribuzione di fondi, invio di armi ai terroristi in tutto il Sudamerica. Ma la Cina è un’altra cosa. La Cina non ha preso parte a tutto ciò. La Cina si è comportata bene”. Coerentemente con tali posizioni il partito maoista argentino, il più direttamente legato a Pechino in America meridionale, dichiarava che nel golpe di Pinochet c’erano aspetti sia negativi che positivi, ma che i secondi erano superiori ai primi, perché si era dato un colpo al socialimperialismo.
Negli anni immediatamente successivi la burocrazia maoista mantenne la sua alleanza controrivoluzionaria con l’imperialismo USA. Così cercò di impedire l’offensiva finale dei nordvietnamiti e del Fronte Nazionale di Liberazione sudvietnamita contro il regime fantoccio di Saigon (i vietnamiti riferirono la seguente frase di Mao in persona: “Io non ho un cucchiaio lungo abbastanza per arrivare a Taiwan, voi non lo avete per arrivare a Saigon”). Così fece pubblico appello con i peggiori arnesi reazionari, come il capo della destra della Democrazia Cristiana tedesca, Franz Joseph Strauss, al rafforzamento della NATO. Così appoggiò lo Scià di Persia e molteplici altri tiranni reazionari contro guerriglie e oppositori vari.
In questo florilegio di posizioni reazionarie si distinse con un suo proprio ruolo il “Grande Timoniere” Mao in persona. Difese il Presidente repubblicano Nixon coinvolto in uno scandalo di spionaggio che lo costrinse nel 1974 alle dimissioni e aprì un momento di crisi dell’amministrazione americana, che favorì effettivamente le forze antimperialiste. Il maopensiero in questo caso fu: “Troppa libertà negli USA... che male c’è a registrare una conversazione? A molti negli USA piace giocare coi registratori”. E fu lo stesso Mao a segnalare che si sentiva in Occidente più vicino ai politici di destra che a quelli di sinistra. Tale era l’approccio alle forze più reazionarie e guerrafondaie antisovietiche, del resto la costante della politica ufficiale cinese.
Essa poté esprimersi pienamente anche in un importante episodio che toccò più direttamente i maoisti nostrani. La rivoluzione portoghese del 1974-‘75 e le dialetticamente scatenanti collegate rivoluzioni nelle colonie portoghesi in Africa.
In Portogallo vi era anche una presenza, seppur limitata, di forze maoiste, comprese alcune a carattere “ortodosso” legate direttamente a Pechino. Queste, non appena si ebbe uno sviluppo della rivoluzione in senso anticapitalistico, si allearono con le forze di destra in nome della lotta prioritaria contro il socialimperialismo, partecipando alle azioni antioperaie nelle zone reazionarie del centro-nord del paese, come l’assalto alle sedi del Partito Comunista e della Centrale Sindacale.
Nella contemporanea guerra civile tra le forze del Movimento Popolare per la Liberazione dell’Angola e quelle filoimperialiste finanziate dagli USA e appoggiate militarmente dal Sudafrica razzista e dal dittatore congolese Mobutu, i cinesi diedero apertamente aiuto militare agli agenti dell’imperialismo (Savimbi a capo dell’UNITA e Holden Roberto a capo del sedicente FNLA), in particolare attraverso la presenza di consiglieri militari nelle loro truppe.
Nel lontano 1976 – in Italia – il Gruppo Bolscevico-Leninista (per la IV Internazionale) [gruppo politico precursore del PCL, ndr], scriveva sul suo organo Il Militante:
“Sostanzialmente le motivazioni di questa politica criminale risiedono nel carattere delle forze dominanti in Cina. Si tratta di una politica diretta unicamente a preservare il potere burocratico conservando lo status quo internazionale dei conflitti inter-burocratici, di apparati statali che non vertono certo sul miglior modo di liquidare la borghesia, ma sul miglior posto ottenibile in un quadro di collaborazione di classe internazionale. Nonostante che l’URSS non sia meno stalinista della Cina, la sua maggiore forza economica e il suo più elevato sviluppo consentono alla sua burocrazia di mantenere la propria “posizione internazionale”, con la garanzia dei propri privilegi, senza dover ricorrere a quegli estremi di collaborazione di classe cui è costretta la burocrazia cinese. Su grande scala, prosegue il caso jugoslavo: la burocrazia più debole che, per tenere testa a quella più forte, rivaleggia con essa per ottenere le grazie dell’imperialismo, si butta alla sua destra e nel caso di conflitti tra burocrazia e imperialismo si accoda a quest’ultimo. Tito, nella mal riposta speranza di una IV Internazionale in via di degenerazione, appoggiò l’intervento americano in Corea. Anche Stalin, naturalmente, aveva i “suoi motivi” per schiacciare o pugnalare alle spalle la rivoluzione europea ed asiatica, e collaborare via via con le “democrazie” imperialiste o con i fascisti. Ufficialmente questi motivi si possono esprimere in termini di convenienza militare, diplomatica, di realpolitik, come mistificazioni di tattica rivoluzionaria, ma in concreto non abbiamo qui le esigenze dello Stato operaio, russo o cinese, della sua tattica o politica realistica rivoluzionaria (includente eventuali compromessi alla Lenin e alla Trotsky, alla Brest-Litovsk), bensì le esigenze dello Stato operaio degenerato-deformato, ossia in primo luogo le esigenze della burocrazia che lo parassita, che lo mette a rischio, che lo tradisce, anche sul piano militare-diplomatico. La realpolitik dello Stato operaio non degenerato, non deformato, coincide con gli interessi del proletariato internazionale e vi è subordinata; la realpolitik burocratica, assoggettando il proletariato internazionale alle manovre senza principio con la borghesia, mina lo stesso Stato operaio. È una sciocca apologia vedere nella politica estera cinese, o staliniana in genere, una semplice questione di convenienza “nazionale”: se questa vi è vi è solo per la burocrazia, non certo per le conquiste rivoluzionarie, per lo Stato operaio, per le masse lavoratrici su cui si fonda; così come le contraddizioni tra gli interessi dello stato operaio e quelli del movimento operaio mondiale sono un’invenzione per abbellire la realtà dell’opposizione inconciliabile tra dominio e politica burocratica e rivoluzione internazionale.”
Nel mentre questa politica controrivoluzionaria si sviluppava i maoisti nostrani, continuavano, anche su questo terreno la politica delle tre scimmiette.
Così, oltre un cinismo senza limiti, i vari Magri, Rossanda, Sofri, Gorla e Vinci, per non parlare dei Capanna, Cafiero e Brandirali, esprimevano la mancanza di ogni reale internazionalismo. Paradossalmente i più internazionalisti dei maoisti erano le sette “m-l ortodosse” che rivendicavano apertamente la politica cinese, giustificandola pienamente. Si trattava però di un internazionalismo controrivoluzionario, potenzialmente portatore anche di un’azione pratica controrivoluzionaria, quella sviluppata dai loro “fratelli” portoghesi.
LA POLITICA NAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI MAOISTE: TRA SOCIALFASCISMO E FRONTE POPOLARE
Se quanto indicato sopra è la politica cinese a cui i maoisti nostrani si adattarono, o che coprirono vergognosamente, quali furono le incidenze sulla loro politica concreta in Italia?
È naturalmente difficile fornire una risposta univoca rispetto a organizzazioni così variegate come quelle che si richiamavano al maoismo nel nostro Paese. In generale, però, si può dire che, in forme diverse, l’arco di riferimento delle varie organizzazioni era dato da due diverse posizioni generali, entrambe proprie, in epoche diverse, della storia dello stalinismo: il “terzoperiodismo” (o socialfascismo) e il “frontepopulismo”.
Con il termine “terzoperiodismo” si indica la fase della politica dell’Internazionale Comunista stalinizzata, e dei partiti comunisti nazionali che ne facevano parte, che va dal 1929 al 1934. In questa fase la burocrazia stalinista in URSS, preoccupata per le possibili conseguenze negative (in primo luogo per il proprio dominio) che il proseguimento della politica di concessioni agli elementi piccolo-borghesi della società attuata negli anni precedenti avrebbe comportato, attuò una brusca svolta “a sinistra”. Il leader politico e teorico della destra del PCUS e dell’Internazionale, Bucharin, fu emarginato, e gli stalinisti ripresero le tanto vituperate proposte di industrializzazione e collettivizzazione dell’agricoltura avanzate nella battaglia politica degli anni ‘20 dall’Opposizione di Sinistra diretta da Trotsky. Solo che, mentre quest’ultima aveva proposto su entrambi i settori, in particolare rispetto alla collettivizzazione agricola, un processo graduale, la burocrazia passò dall’opportunismo all’avventurismo con metodi brutali, realizzando l’industrializzazione e la collettivizzazione “forzati”. Quest’ultima provocò nelle campagne milioni di morti, in parte a causa delle carestie determinate dalla sua attuazione e in parte per la violenta resistenza dei contadini, che determinò situazioni di contraddizione che indebolirono per sempre l’agricoltura dell’URSS. Sullo stesso terreno dell’industrializzazione, dove si ottennero a prezzo di grandi sacrifici per le masse importanti risultati, lo squilibrio tra lo sviluppo dell’industria pesante e quello, mancato, dei beni di consumo, non sarebbe stato privo di conseguenze, per le contraddizioni che indebolirono l’URSS in tutta la sua vita successiva.
Sul piano estero l’Internazionale, oramai tale solo di nome, in quanto diventata espressione degli interessi della burocrazia dominante dell’URSS, fu portata anch’essa ad adeguarsi a tale politica avventurista con un salto politico, presentato appunto come il “terzo periodo” dell’Internazionale stessa (dopo quello dell’epoca leninismo e quello della parte centrale degli anni ‘20). Di fronte alla crisi mondiale del capitalismo (il crollo borsistico del ‘29 e la conseguente fase di depressione su scala mondiale), lo scenario che veniva prospettato partiva dall’assunzione catastrofista dell’impossibilità di uscirne. In questo quadro, con una visione meccanica e non dialettica del rapporto tra crisi e coscienza delle masse, si pronosticava e si analizzava ovunque lo sviluppo di situazioni rivoluzionarie. Di fronte a ciò, secondo gli stalinisti, tutte le forze politiche si trasformavano “fascistizzandosi” e, in questo quadro, la socialdemocrazia veniva considerata “socialfascista”, diventando addirittura il nemico principale per il suo ruolo di direzione della maggioranza del movimento operaio. Così si lasciavano cadere tutte le basi della tattica leninista stabilita nei primi quattro congressi dell’Internazionale Comunista. Al posto della lotta per il fronte unico del movimento operaio, la completa contrapposizione settaria con i settori riformisti accompagnata al massimo da qualche appello ultimatistico per un “fronte unico dal basso” alla base della socialdemocrazia; al posto della lotta per la conquista dei sindacati diretti dai riformisti, la scissione sindacale, con la costituzione di “sindacati rossi” di minoranza sotto la stretta direzione dei vari partiti comunisti. Tutte queste posizioni potevano essere confuse con l’ultrasinistrismo che avevano espresso alcuni settori dell’Internazionale Comunista al momento della sua fondazione. In realtà, oltre ad essere di un livello teorico meno elaborato, le posizioni settarie del terzo periodo si combinavano con altre manifestamente opportuniste, come il richiamo al concetto aclassista di “rivoluzione popolare” (come contenuto programmatico, non come carattere sociale nel senso leninista del termine) di “liberazione nazionale”, anche in paesi imperialisti come la Germania, con demagogie populiste e alleanze con settori e personalità piccolo-borghesi, a condizione che accettassero di subordinarsi all’egemonia organizzativa degli stalinisti.
Si trattava in realtà di una politica di tipo centrista, per quanto di sinistra, espressione di come la burocrazia dell’URSS considerava necessario sviluppare sul piano internazionale la sua difesa. Ed è esattamente per questo che i trotskisti dell’epoca la definirono “centrismo burocratico”. Il risultato di tale politica fu nel 1933 il disastro tedesco. Il settarismo centrista burocratico del Partito Comunista di Germania si combinò col piatto riformismo della socialdemocrazia nell’impedire l’unità dei proletari tedeschi contro il nazismo, che così trionfò. Gli stalinisti giunsero a salutare la vittoria di Hitler proclamando “Dopo Hitler, noi”, convinti che il governo nazista avrebbe provocato rapidamente la rivolta del proletariato sotto la guida del Partito Comunista. Sappiamo come sono andati i fatti.
Di fronte a tanta disfatta e senza tirare alcun bilancio della politica passata, l’Internazionale stalinista passo al lato opposto lanciando con il VII congresso del 1935 la politica dei “fronti popolari”, cioè l’alleanza non solo con la socialdemocrazia ma anche con la cosiddetta “borghesia democratica” (e sul piano statale con gli imperialisti “democratici”), sulla base di una politica borghese di contenimento delle spinte rivoluzionarie del proletariato. Si trattò dell’aperto passaggio ad una politica controrivoluzionaria, che in Spagna e in Francia impedì la rivoluzione proletaria e aprì la via al trionfo del fascismo, di fronte ad un proletariato sconfitto dalle sue stesse direzioni.
Le organizzazioni maoiste in Italia, così come in Europa e nel mondo, combinarono, a volte in congiunzione e a volte in periodi distinti, le due politiche suindicate: il “terzoperiodismo” e il “frontepopulismo”. Il miracolo di unire il tutto spettò alle organizzazioni “m-l ortodosse”, che in realtà unirono ad esse, come abbiamo visto nell’esempio portoghese, anche quella politica di blocco con il fascismo che fu per breve tempo il nuovo zig-zag degli stalinisti dopo i “fronti popolari”, all’epoca cioè (1939-‘41) del patto Hitler-Stalin: una politica che, come Trotsky giustamente sottolineò, fu l’unica realizzazione concreta di quel concetto di socialfascismo tanto invocato dagli stalinisti. La scarsa incidenza degli “m-l ortodossi” in Italia dopo il 1968 fece sì che le loro posizioni opportunistiche restassero sul piano meramente propagandistico.
Diverso fu il ruolo svolto dalle più grandi organizzazioni dell’estrema sinistra. Per esse si possono distinguere due periodi: quello che va dal 1968 al 1972 e quello dal 1974 al 1976, con il 1973 come momento di crisi parziale (si parlò allora di “crisi dei gruppi”) e di passaggio.
Nel primo periodo l’elemento dominante, sia pure in salsa modernizzata da “nuova sinistra”, fu di tipo “terzoperiodista”. Nessun tentativo di fronte unico, rifiuto di ogni sostegno elettorale ai riformisti e in generale, prima del 1972 per Il Manifesto e Servire il Popolo, anche di ogni presentazione elettorale (ma Avanguardia Operaia e Lotta Continua furono astensioniste anche loro in quell’occasione). Sul piano sindacale, proprio nel momento in cui più sarebbe stato importante di fronte a una grande ascesa della lotta di classe combattere la politica di freno delle burocrazie sindacali smascherandone il contenuto di fronte ai lavoratori organizzati e lottare per la democrazia operaia a tutti i livelli del sindacato, in primis della CGIL, le organizzazioni principali di estrema sinistra, in particolare Avanguardia Operaia e Lotta Continua, scelsero di stare fuori dalla Confederazione costruendo proprie microstrutture di simpatizzanti e utilizzandole non come strumento di intervento nel sindacato ma per contrapporsi organizzativamente ad esso. Quando la lotta dei lavoratori del 1969-‘70 diede vita al più importante strumento di organizzazione di massa, cioè i Consigli dei Lavoratori, Lotta Continua giunse a condannarli e a contrapporsi frontalmente ad essi con lo slogan cretino “siamo tutti delegati”. Queste diverse ma convergenti politiche da “terzo periodo” potevano marginalmente reggere nel momento in cui si sviluppava un grande movimento di massa e, sebbene in complesso rafforzassero il controllo dei riformisti sul movimento operaio, potevano “mordere”, malgrado tutto, su alcuni suoi settori minoritari.
Ma quando nel 1972-‘73 seguì all’ascesa una fase di calo nello scontro di classe, tali strategie cominciarono a diventare suicide e appunto portarono alla crisi politica. Di fronte a ciò le organizzazioni maoiste operarono una svolta, ma, appunto, ponendo il segno più dove prima avevano messo il meno, e riproponendo una politica centrista di destra, a carattere sostanzialmente “frontepopulista”, che si sviluppò organicamente nella nuova fase di ascesa del 1974-‘76. Sul terreno sindacale si passò dalla condanna dei Consigli all’esaltazione del “Sindacato dei Consigli” (cioè della subordinazione dei consigli di fabbrica alla burocrazia sindacale). Si decise l’ingresso nei sindacati confederali, ma invece privilegiare la CGIL per la sua composizione di base si scelse in prevalenza l’ingresso nella CISL e nella UIL che, dotate di una burocrazia meno forte e demagogicamente in alcuni momenti “sinistreggiante”, accoglievano i nuovi quadri provenienti dall’estrema sinistra come medi burocrati “radicali” (salvo porli, in una fase successiva, di fronte alla scelta tra l’adattamento totale e – particolarmente la CISL – l’espulsione). Al posto dell’astensionismo della fase precedente si cominciò (giustamente) a praticare la presentazione elettorale. Ma dato che i primi risultati, sulla base dell’allora sistema proporzionale quasi integrale, diedero un inizio di presenza nei consigli comunali, si passò ad esaltare il ruolo della sinistra nelle istituzioni locali, quasi indicando una specie di via “municipale” verso il socialismo.
Il terreno su cui il passaggio a destra fu più evidente fu, come ovvio, quello politico generale. Dal rifiuto di ogni politica di fronte unico si passò al terreno del “frontepopulismo”. Questo il senso della rivendicazione di un “governo delle sinistre”, che Lotta Continua precisò nella formula “il PCI al governo con una DC spaccata e divisa”. La coalizione elettorale di tutte le forze dell’estrema sinistra, che assunse il nome di Democrazia Proletaria (che una parte dei suoi componenti doveva successivamente assumere come nome di partito), aveva appunto lo scopo di porsi come componente estrema di questo schieramento di fronte popolare. La realtà (come allora unico nell’estrema sinistra previde solo il piccolo Gruppo Bolscevico-Leninista) fu diversa, dando vita ad un governo di unità nazionale ancora centrato sulla Democrazia Cristiana ed il PCI a sostegno, ma senza ingresso organico. Questa inattesa (per l’estrema sinistra maoista) soluzione e il modestissimo (1,5%) risultato di Democrazia Proletaria provocarono un vero terremoto nell’estrema sinistra e furono alla base della repentina scomparsa di Lotta Continua, mentre PdUP e AO si scindevano entrambe, dando vita a una ricomposizione intrecciata nel nuovo PdUP (che, unitosi al MLSm confluirà a metà anni ‘80 nel PCI) e nella nuova Democrazia Proletaria, la debole struttura di partito che perdurerà fino alla nascita di Rifondazione Comunista, in cui confluirà.
PER UN FUNERALE DI TERZA CLASSE DI TUTTO CIÒ CHE RESTA DELL’IDEOLOGIA MAOISTA
Fu in questo quadro di confusione, scissione o dissoluzione che le varie organizzazioni maoiste o maoisteggianti si trovarono di fronte, alla fine del 1976, alla svolta seguita alla morte di Mao, con la liquidazione della “banda dei quattro” capeggiata dalla moglie di Mao, Chiang Ch’ing, ed il successivo trionfo dell’ex “reprobo” Deng. Gli “m-l ortodossi” si divisero: in Italia in maggioranza condannarono la nuova svolta, sperando la salvezza prima dal Partito Comunista Albanese, poi per molti, con un incredibile voltafaccia, dalla burocrazia sovietica, quella che pochi anni prima avevano etichettato come socialfascista o fascista tout court. Le altre organizzazioni, per cui come detto il rapporto con la burocrazia cinese era assai più labile, si limitarono a cronache e commenti in generale anodini. La loro crisi in Italia era il loro problema più importante e il quadro estero lo era sempre meno.
Se fosse esistita una significativa presenza trotskista si sarebbe potuto utilizzare questa situazione per una ampia battaglia di chiarificazione e di conquista al marxismo militante di molti militanti. Purtroppo, queste condizioni oggettive non esistevano. Il GBL non era che una piccola organizzazione di poche decine di militanti, mentre i Gruppi Comunisti Rivoluzionari - IV Int. (Maitan) pablisti, anche essi di modeste dimensioni nonostante fossero 15 o 20 volte superiori ai GBL, ancora una volta non riuscirono ad intervenire positivamente a causa dei loro errori politici. Si erano infatti, nel 1975-‘76, accodati totalmente a Lotta Continua, individuata come nucleo del futuro partito rivoluzionario. Con essa avevano, marginalmente per la loro debolezza, partecipato all’esperienza di Democrazia Proletaria e sostenuto la prospettiva di un fronte popolare. Con Lotta Continua e l’insieme delle altre organizzazioni dell’estrema sinistra i GCR entrarono in crisi nel 1977. Una crisi che giunse nuovamente a porne in forse l’esistenza. Si salvarono, dopo aver perso una buona parte dei militanti, trasformandosi in Lega Comunista Rivoluzionaria grazie all’importante intervento dell’Internazionale (allora in una breve svolta di serietà organizzativa), ma certo non furono in grado di sfruttare le potenzialità della situazione.
Ecco perché, slegato ormai da ogni politica concreta della Cina e legata invece al mito della Rivoluzione culturale, il maoismo ha continuato per lungo tempo a permanere appunto come vaga ideologia, e tuttavia come ostacolo contro il marxismo.
Note:
[1] Secondo la teoria di Lin Piao, le masse popolari dovevano affrontare lo scontro militare possibile o probabile con l’imperialismo non sulla base dei criteri generali della guerra “tradizionale”, ma con una guerra di “popolo” a carattere essenzialmente contadino, in un processo in cui “le campagne accerchieranno le città”. Si trattava astrattamente di una generalizzazione dell’esperienza della rivoluzione cinese (anche se va ricordato che le battaglie essenziali della rivoluzione cinese nel 1948-’49 si svolsero come battaglie campali e la vittoria arrise ai maoisti anche per il passaggio di interi settori dell’esercito nazionalista dalla loro parte e per il dissolvimento di altri) e di quella vietnamita. Ma in concreto il suo significato, rivolto in primo luogo ai vietnamiti, impegnati nello scontro contro l’imperialismo USA, che proprio in quell’anno aveva deciso l’intervento massiccio diretto del proprio esercito nella guerra, era: “Non vi sognate che rischiamo di ripetere la Corea, con un coinvolgimento significativo al vostro fianco, in alleanza all’URSS: state già facendo una guerra di popolo, molto bene, continuate e arrangiatevi da soli”.